
In questi giorni, chiunque abbia seguito il dibattito sull’Intelligenza Artificiale ha avuto l’impressione di assistere a una sorta di “incantesimo mediatico”: l’IA viene celebrata come un miracolo tecnologico, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per risollevare l’economia e proiettarci tutti in un luminoso futuro. Ma non tutti sono così convinti. Il filosofo e saggista Éric Sadin, con toni decisi, ci ha ricordato che dietro gli slogan di progresso e innovazione si nasconde una realtà molto più complessa – e che merita un’attenzione urgente.
Il Vertice francese sull’IA (10-11 febbraio) e i retroscena poco noti
Gli occhi di politici, manager dell’hi-tech e accademici si sono concentrati su Parigi, in occasione di un Vertice sull’Intelligenza Artificiale che, almeno sulla carta, prometteva di fare il punto sull’impatto di questa tecnologia nella società. Ufficialmente, si è discusso di come l’IA possa migliorare la vita quotidiana, potenziando settori cruciali come la sanità, la tutela ambientale, i trasporti e perfino l’istruzione. Ma, come spesso accade, la patina scintillante degli annunci si è rivelata in parte un’operazione di marketing: poco o nulla si è detto, per esempio, di come evitare gli abusi o di chi pagherà le conseguenze più dure del cosiddetto “progresso”.
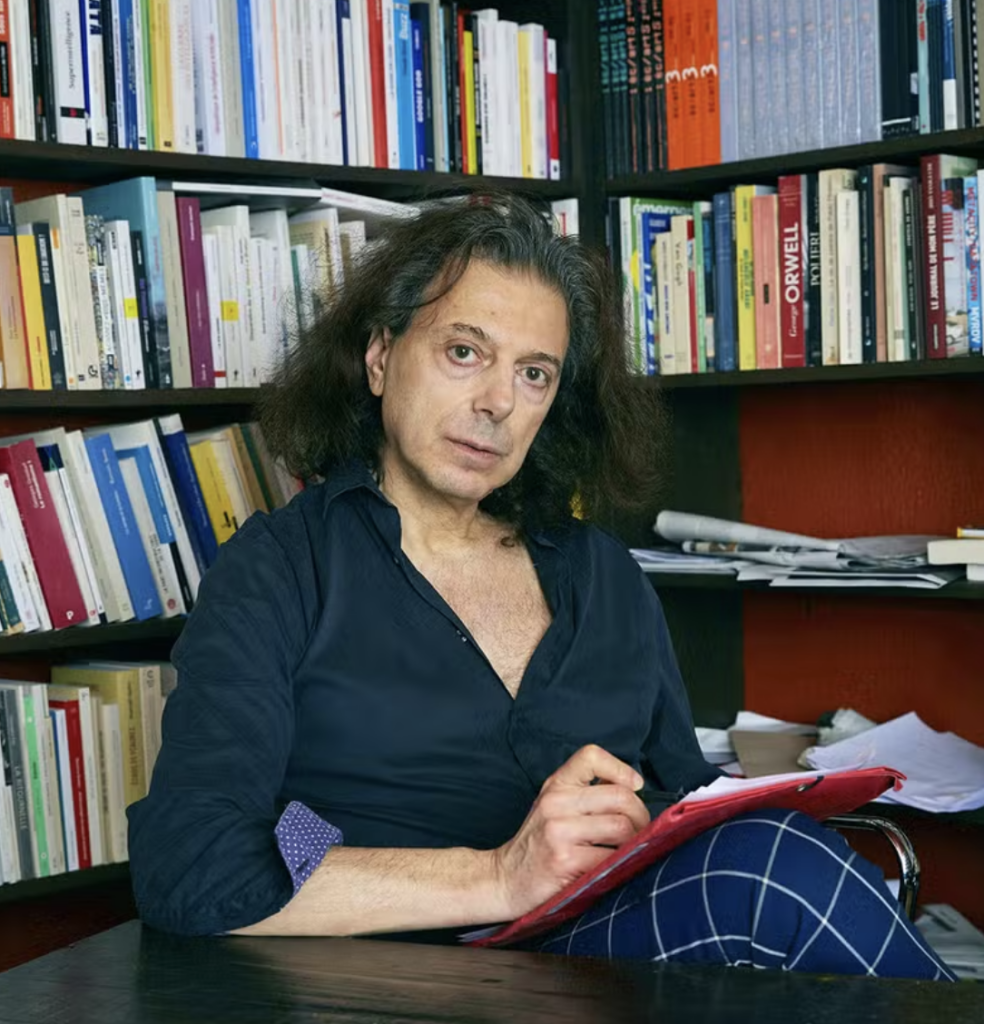
Proprio su questo tasto ha insistito Sadin, sottolineando come l’evento, a suo dire, sia stato dominato da interessi economici e dalla volontà di attirare capitali pubblici e privati. In poche parole, un grande palcoscenico per convincere i governi e il mercato che l’IA sia l’unica strada percorribile. Non stupisce quindi se, di fronte a tanta enfasi, Paesi come Stati Uniti e Cina non mostrino alcuna intenzione di mettere limiti o regole: ognuno vuole mantenere il suo primato, e il terreno di gioco sono miliardi di investimenti. Nel frattempo, l’Europa resta incerta: impaurita all’idea di farsi sorpassare in questa gara di capitale tecnologico, ma allo stesso tempo preoccupata da un’innovazione che rischia di sgretolare interi settori lavorativi e culturali.
Il prezzo pagato dagli artisti e dalla cultura
Uno dei punti più caldi messi in luce da Sadin riguarda il mondo artistico e culturale. Sempre più spesso, i software di IA generativa pescano a piene mani da testi, immagini, brani musicali e video prodotti da artisti in carne e ossa, senza un reale riconoscimento economico o morale. Ciò che inizialmente poteva sembrare una bizzarria digitale si sta trasformando in un meccanismo pervasivo: le “macchine” prendono spunto da centinaia di opere, mixano, rielaborano, generano qualcosa di nuovo e poi lo propongono al pubblico. Ma quel “qualcosa di nuovo” è in realtà il frutto di migliaia di mani e menti umane, il cui lavoro rischia di essere cannibalizzato e sminuito.
Il parallelo con la rivoluzione della fotografia o del cinema, spiega Sadin, non regge: in quei casi, si trattava di strumenti che potenziavano la creatività, permettendo a scrittori, pittori e registi di sperimentare nuovi linguaggi. L’IA, invece, si limita (per ora) a “succhiare” ispirazione da tutte le opere presenti in rete, ricombinandole con algoritmi sofisticati. La preoccupazione è che, alla lunga, questo processo conduca a una standardizzazione delle idee e a un impoverimento dell’originalità artistica.
Il timore di perdere il lavoro
Non meno rilevante è l’impatto sull’occupazione. Al vertice, esponenti di diverse aziende hanno parlato di “sinergie uomo-macchina” e di “opportunità di crescita”, ma Sadin avverte che, dietro questi termini rassicuranti, molte professioni potrebbero sparire o trasformarsi radicalmente. Insegnanti, traduttori, redattori editoriali, autori di film d’animazione – solo per citarne alcuni – stanno già sperimentando una pressione crescente dovuta all’uso di software sempre più precisi e autonomi. L’intervento umano, in molti casi, è destinato a ridursi a un semplice controllo o correzione, spesso sottopagato.
La scuola è forse l’esempio più delicato: piattaforme basate sull’IA promettono un “monitoraggio personalizzato” di ogni studente, ma non c’è alcuna garanzia che ciò si traduca in un miglioramento della didattica. Anzi, se l’uso dell’IA diventa un alibi per investire meno su insegnanti qualificati e metodi di apprendimento realmente partecipativi, potremmo ritrovarci con generazioni di ragazzi che sanno utilizzare (o subire) algoritmi brillantemente, ma faticano a sviluppare capacità critiche e creative autonome.
Un contro-vertice per ridare voce ai cittadini
Nel corso delle stesse giornate, un piccolo ma significativo contro-vertice ha provato a offrire una visione alternativa. A partecipare erano insegnanti preoccupati, artisti che vedono il proprio lavoro svilito da software che generano migliaia di “cloni” in pochi secondi, e professionisti dell’editoria e del cinema che si chiedono quale futuro li attenda. I loro racconti, spesso carichi di frustrazione, hanno richiamato l’attenzione su un elemento finora trascurato: chi decide le regole del gioco?
Secondo Sadin, troppo spesso sono le multinazionali del digitale a dettare l’agenda, in un contesto dove Stati Uniti e Cina si contendono la supremazia e l’Europa, colma di dubbi, rischia di trovarsi schiacciata. Le norme e le politiche da varare richiedono coraggio e visione a lungo termine, ma anche la capacità di investire in modo massiccio per non restare indietro.
Due visioni a confronto
È qui che si incrociano due visioni distinte del mondo. Da una parte, il “capitalismo digitale”, che punta all’efficienza e all’ottimizzazione, spesso a scapito di un lavoro dignitoso e di un’autentica libertà creativa. Dall’altra, una prospettiva umanistica, centrata sulla persona, sulla tutela dei diritti e sul riconoscimento del valore insostituibile della creatività umana. La sfida è aperta: riuscire a trovare un equilibrio tra innovazione e salvaguardia dei principi fondamentali della nostra società.
Non c’è più tempo da perdere
L’appello di Sadin risuona come un monito: se non si interviene adesso con regole chiare e una riflessione condivisa, potremmo trovarci a rimpiangere di aver consegnato le chiavi del futuro a macchine programmate per massimizzare profitti e velocità, senza considerare il fattore umano. Mentre Stati Uniti e Cina vanno avanti senza remore, e in Europa si dibatte su quale posizione assumere, è in gioco non solo la competitività economica, ma anche il nostro modo di essere comunità e di concepire la cultura.
Forse è giunto il momento di fermarsi un attimo, spegnere la retorica che tutto procede nella direzione giusta, e ascoltare le voci di coloro che vivono sulla pelle gli effetti di questa rivoluzione digitale. Nella speranza che, un giorno, l’IA possa davvero rappresentare un alleato prezioso – e non una minaccia silenziosa pronta a ridimensionare la dignità e la creatività di intere generazioni.
